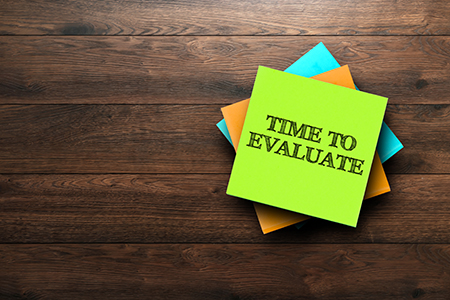 La Redazione di Valu.Enews ha incontrato nelle settimane scorse Gabriele Tomei e Donatella Poliandri, rispettivamente Presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione (AIV) e Componente del Direttivo della stessa associazione scientifica.
Gabriele Tomei è Professore Associato di Sociologia Generale al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, Donatella Poliandri è Primo Ricercatore INVALSI e Responsabile dell'Area di Ricerca Innovazione e sviluppo e del Progetto PON Valu.E.
L'intervista doppia promossa da Valu.Enews si presenta quale momento di confronto e rendiconto dopo due significativi momenti di riflessione scientifica che l'AIV ha promosso nei mesi dell'emergenza pandemica in corso, quale contributo alla valutazione delle politiche pubbliche promosse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsto per i prossimi anni nell'ambito del Programma Next Generation Italia.
Il 16 aprile scorso, in particolare, l'AIV ha promosso una Tavola Rotonda, con la partecipazione di Gabriele Tomei e Donatella Poliandri in rappresentanza del Direttivo AIV, dal titolo Valutando si impara: saperi esperti per la valutazione delle politiche e il rilancio del Paese, nella quale sono stati invitati a partecipare i presidenti delle principali società scientifiche del nostro Paese. Gli altri relatori che hanno presentato contributi scientifici sono stati Corrado Crocetta dell'Università di Foggia e Presidente della Società Italiana di Statistica (SIS); Gabriele Ballarino dell'Università di Milano e Presidente della Società Italiana di Sociologia Economica (SISEC); Maria Carmela Agodi dell'Università di Napoli e Presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS); Francesca Longo dell'Università di Catania e Presidente della Società Italiana di Scienza Politica (SISP); Romilda Rizzo dell'Università di Catania e Presidente della Società Italiana di Economia Pubblica; e Massimo Tommasoli di IDEA International, Consigliere della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA). Una registrazione dell'iniziativa è presente sulla piattaforma Vimeo previa registrazione sulla stessa.
Quale momento di contributo istituzionale, nelle settimane seguite alla Tavola Rotonda, i partecipanti alla stessa hanno deciso di redigere una Lettera aperta che è stata recapitata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono state sintetizzate le principali riflessioni emerse nel corso della giornata di studi, al fine di poter migliorare gli interventi di monitoraggio previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sabato 15 maggio, infatti, è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la lettera aperta sottoscritta delle sei Società Scientifiche italiane coinvolte, al fine di incoraggiare il Governo ad investire nella valutazione delle politiche di rilancio del Paese.
La Redazione di Valu.Enews ha deciso di approfondire con Gabriele Tomei e Donatella Poliandri questi rilevanti temi di interesse pubblico nazionale, anche al fine di diffondere la cultura della valutazione in un momento cruciale per la ripresa economica e sociale del nostro Paese.
Gabriele Tomei, Lei è il nuovo Presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione (AIV) da pochi mesi, quali prime impressioni dall'inizio del suo mandato, in un contesto sociale ed economico tanto complesso per gli orizzonti nazionale e internazionale?
«Il nuovo Direttivo dell'AIV si è insediato in un momento molto difficile, lo scorso ottobre, ritenendo sin dall'inizio strategica la necessità di proseguire e amplificare l'azione intrapresa dal Direttivo precedente, sulla base di una linea di continuità, tesa principalmente a rafforzare la community degli associati sia dal punto di vista dell'attrazione dell'Associazione nei confronti dei giovani sia nei confronto di coloro che incontrano la valutazione per la prima volta, all'insegna di un maggiore radicamento sui territori e in collaborazione con i centri di ricerca che si occupano delle diverse tematiche. Un altro aspetto prioritario cui stiamo dedicando particolare impegno è rappresentato dalla qualificazione della Rassegna Italiana di Valutazione (RIV), che vogliamo valorizzare sempre più, soprattutto dal punto di vista della qualità delle pubblicazioni che essa accoglie e dei temi che essa affronta. Infine un grande sforzo di internazionalizzazione e maggior collegamento con le altre centrali valutative a livello internazionali, tra cui l'European Evaluation Society, ove l'AIV siede attraverso la collega Laura Fantini, e il Network of European Societies of Evaluation (NESE), ove recentemente è stato nominato Nicola Orlando, altro collega del Direttivo».
Donatella Poliandri, Lei ha coordinato la recente Tavola Rotonda AIV sulla valutazione delle politiche per il rilancio del paese, tema strategico per il futuro in questa fase di ripresa dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto. Da dove nasce l'esigenza di questo confronto?
«La necessità di promuovere questa tavola rotonda come AIV sta nelle cose, nella fase che stiamo attraversando: i cambiamenti – sconvolgimenti – ambientali, demografici e socioeconomici, in una situazione di sempre maggiore globalizzazione delle emergenze (dalla crisi sul clima a quella sanitaria attuale), ci interrogano come studiose e studiosi da molti punti di vista. Sappiamo che l'azione politica deve comprendere e affrontare al meglio questi continui mutamenti, mettendo al riparo dai rischi, contenendo la paura, fronteggiando le sfide e cercando di cogliere tutte le opportunità di cambiamento anche positive che il momento storico ha posto sia di fronte al Paese, sia di fronte a ciascuno di noi. Quale peso dobbiamo affrontare come cittadini? Cosa grava su tutti i livelli decisionali pubblici? E dove e come si esplica la responsabilità strategica dei processi che si attuano a seguito delle decisioni prese? Siamo sul liminare di un cambiamento e possiamo considerare come cruciale la necessità di fare emergere – oggi più che mai – modi democratici ed equi per affrontare queste sfide. Ecco, come AIV pensiamo che lo ‘sguardo valutativo', ovvero la valutazione, possa essere uno di quei modi, senz'altro a nostro avviso uno dei più rilevanti».
Con quale approccio ritiene che la valutazione delle politiche pubbliche possa affrontare il difficile contesto attuale?
«Oggi siamo di fronte a un'esigenza rilevante: quella di utilizzare in modo efficace e strategico le risorse economiche che già sono in campo – e che ancora di più arriveranno nei prossimi mesi – per garantire la ripresa del nostro Paese. Ecco perché, per comprendere meglio le politiche che attengono alle scelte economiche che saranno attuate, riteniamo sia giunto il momento di mobilitare tutte quelle conoscenze e competenze che da quasi un secolo hanno concorso al consolidamento dello ‘sguardo valutativo' sulle politiche pubbliche. Mi riferisco chiaramente a quelle che, fra le altre, abbiamo chiamato a raccolta nella tavola rotonda ossia politologiche, sociologiche, economiche, statistiche, psicologiche e antropologiche. Non certo con l'obiettivo di immaginare la costruzione di dispositivi amministrativi di controllo e sorveglianza o preoccupandoci – o almeno, non certo preoccupandoci unicamente – della validità e attendibilità delle procedure di raccolta dei dati, ossia solo di quegli aspetti di ricerca tout court che più facilmente ci interessano come studiosi, pur certo molto rilevanti per garantire il metodo dei processi di valutazione. Ma anche e soprattutto mi riferisco alla necessità di disseminare occasioni di apprendimento sistematico e processi di miglioramento basati sull'evidenza. Sentiamo dunque la necessità di riflettere insieme anche su alcuni aspetti specifici concernenti la rilevanza delle politiche pubbliche individuate; ad esempio, pensiamo al rapporto che intercorre tra la valutazione e l'etica (un esempio su tutti ha a che fare con le politiche che si stanno compiendo a livello comunitario sul piano vaccinale). O l'utilizzabilità degli esiti della valutazione da parte di quei soggetti che poi dovranno essere sui territori, nei luoghi di lavoro, nei luoghi decisionali a tutti i livelli, i veri agenti del cambiamento, promuovendo dunque l'elaborazione di un disegno istituzionale di governance di questi processi che si sostanzi in un cambiamento negli assetti organizzativi, tale da garantire una reale indipendenza della valutazione a tutti i livelli».
Gabriele Tomei, Lei è tra i principali promotori della Lettera aperta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da quale consapevolezza siete partiti nel decidere di indirizzarvi all'esecutivo?
«Nel testo dell'ormai noto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è prevista un'attività di monitoraggio anche se non è prevista un'attività strettamente valutativa, nel senso ampio con cui oggi intendiamo la valutazione quale ricerca che miri a capire cosa si sia fatto, cosa una politica sia riuscita a realizzare, nonché in quali circostanze e a beneficio di chi una politica sia stata messa in atto. L'attenzione al “come”, inoltre, è davvero fondamentale per seguire l'evoluzione dei processi che sottendono ciascun intervento messo in atto. Tutte queste domande attualmente non trovano risposta. Ciò è giustificabile perché il PNRR ha una struttura di finanziamento sulla base della quale le risorse verranno erogate dall'Unione Europea soltanto a rendiconto di risultati raggiunti sulla base di step di avanzamento, in una modalità differente dai fondi strutturali, ponendo l'attenzione soprattutto sui risultati di avanzamento che ciascuna procedura riuscirà ad apportare. Sicuramente nell'ambito del PNRR abbiamo assistito ad un grande sforzo da parte della cabina di regia rispetto al monitoraggio, affidandosi allo stesso software che segue l'operatività dei fondi strutturali, ma oggi occorre più propriamente chiedersi anche quali siano i fattori in grado di influenzare la funzionalità di ciascuna policy. Comprendere per tempo quali siano i meccanismi virtuosi atti a produrre risultati rappresenterebbe quindi un significativo vantaggio, così come quali evenienze possano invece rappresentare degli incidenti di percorso rispetto a determinate linee di policies, a seconda dell'impatto dimostrato sui diversi territori. In particolare oggi occorre una significativa capacità di decentrare lo sguardo valutativo a livello locale e a seconda dei diversi temi in oggetto. Se noi non riusciremo a dotarci di una struttura in grado di lavorare su questo, potremo raggiungere solo determinati risultati, certo non ad ampio raggio. Ecco perché la lettera aperta che l'AIV ha patrocinato, in collaborazione con le principali società scientifiche che l'hanno sottoscritta, può rappresentare un pungolo rispetto all'azione governativa».
Donatella Poliandri, come membro del Direttivo dell'AIV, quale valore aggiunto ritiene che l'Associazione di ricerca possa imprimere nella direzione di una sempre maggiore attenzione agli aspetti valutativi nella messa a sistema delle politiche?
«Mai come in questa fase è necessario uno sforzo comune delle istituzioni, delle parti sociali e di tutti i saperi per concorrere all'individuazione e all'accompagnamento dei percorsi di ripresa. I sistemi delle conoscenze accademiche e della ricerca e delle competenze professionali hanno, pertanto, a nostro avviso il compito di contribuire a questo sforzo, mettendo le proprie capacità analitiche e riflessive al servizio del rilancio del Paese. Una delle riflessioni emerse dalla tavola rotonda e condivisa dai partecipanti è stata, in particolare, quella relativa alla necessità di intensificare il dialogo fra le discipline e ‘fra' e ‘con' gli altri saperi esperti del settore valutativo con l'obiettivo di accrescere la rilevanza della valutazione e rafforzarne gli esiti, nonché la ‘voce'. Come spesso accade nelle occasioni di riflessione e confronto scientifico promosse dall'AIV emerge la necessità di promuovere sempre più la cultura della valutazione, ma non in via adempimentale, bensì mobilitando i saperi (le tecniche e le pratiche) in modo plurale e multidisciplinare, promuovendo una valutazione che sappia non solo valutare se e quanto un determinato obiettivo sia stato raggiunto, ma che interpreti e comprenda anche i processi per tenere in equilibrio molti aspetti, quali, ad esempio, quelli etici, di genere, ma anche – come sottolineava il Professor Tomei – gli aspetti relativi al complesso rapporto fra il centro e la periferia. In questo senso, emerge il ruolo cruciale della Pubblica Amministrazione: il PNRR si può trasformare in un esercizio di apprendimento senza precedenti che potrebbe trasformare la PA. Questo significa però anche avvalersi di quanto già è stato fatto e appreso e valorizzarlo. Non si tratta infatti solo di valutare programmi e progetti, si tratta di renderli esigibili e in grado di fornire un contributo teso al miglioramento che dovrebbe essere al contempo interiorizzato dalla PA, secondo una prospettiva di apprendimento istituzionale: la qualità della governance e del processo di valutazione va di pari passo con la qualità del sistema istituzionale. Da questo punto di vista è anche emersa come pregnante la dimensione territoriale e partecipata della valutazione e l'esigenza di raccogliere ‘le storie di successo', auspicando una competenza sempre più diffusa e decentrata della valutazione».
Tomei, proprio quest'anno Lei ha curato l'edizione di un volume che può dare un ulteriore contributo alla ricerca interdisciplinare e collaborativa: stiamo parlando del libro Le reti della conoscenza nella società globale, pubblicato per Carocci. Perché il tema dei partenariati di ricerca è divenuto sempre più all'ordine del giorno, quale leva strategica per la promozione del miglioramento della ricerca?
«Il libro Le reti della conoscenza nella società globale. Possibilità, esperienze e valore della mobilitazione cognitiva (2021) rappresenta il risultato delle ricerche condotte in un Progetto di Ricerca coordinato dall'Università di Pisa, nell'ambito del quale abbiamo discusso su diversi fronti su quale possa essere il valore aggiunto di una conoscenza prodotta collettivamente. Dentro questo tema, ritengo che l'asse più pertinente rispetto alla valutazione sia quello della conoscenza prodotta all'interno dei partenariati. Un elemento di indagine che oggi mi sembra particolarmente utile è il far luce sulla collaborazione tra istituzioni diverse che però gravitano su uno stesso territorio, chiamate alla sfida dell'identificazione dei bisogni del proprio territorio di appartenenza. Sicuramente non è sempre semplice la strada della condivisione degli obiettivi di ricerca, ma l'approccio valutativo che deve situarsi alla base delle reti di ricerca è quello che renda compatibili risorse e modalità operative anche tra enti tra loro differenti. La riflessione valutativa deve essere ispirata a una pluralità di prospettive diverse favorite dalle capacità di analisi di ciascun stakeholder coinvolto: solo nella misura in cui saremo capaci di far sintesi tra questa molteplicità di riflessioni teoriche e operative, allora diventeremo realmente capaci di “fare sistema”. Lo stesso PNRR, nella misura in cui saprà muoversi su più piani diversi, scendendo dal livello nazionale al livello regionale o interregionale, potrà rispondere alla sfida di fare rete e intrecciare diverse strategie già presenti nelle comunità locali, favorendo la collaborazione e non la mera strutturazione di silos finanziari. In Italia, da questo punto di vista non mancano certo le buone pratiche, è il caso dei GAL, quali partenariati di sviluppo e progetto in area rurale, così come di alcuni partenariati del Fondo Sociale Europeo sul tema dell'inclusione sociale ed educativa o, come, da ultimo, è il caso di alcuni fondi per le aree interne che strutturalmente prevedono quale imprescindibile la costituzione di partenariati di ricerca. In tutti questi casi possiamo osservare come non vi sia certamente alcuna bacchetta magica che dica come si sta insieme ma possiamo osservare la determinazione di tanti soggetti diversi ad elaborare un pensiero nuovo e diverso dalla somma dei soli obiettivi di ciascun membro preso al singolare».
Qual è il ruolo, in questo senso, delle “reti della conoscenza” e delle “comunità educanti”?
«Un saggio che abbiamo pubblicato nel libro si occupa delle procedure di costruzione della conoscenza nelle diaspore scientifiche, vale a dire in quelle reti che sono costituite da soggetti di ricerca qualificati, fra cui dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori che si trovino all'estero ma che pur mantengano un collegamento con le proprie università di origine, o con colleghe e colleghi che siano rimasti in patria o lavorino in altre parti del mondo. Sicuramente osservare il lavoro di questi network diviene oggi molto rilevante anche per offrire un altro punto di vista rispetto al mantra della cosiddetta “fuga dei cervelli” di cui oggi spesso sentiamo parlare. Possiamo quindi leggere “in positivo” il confronto continuo tra queste professionalità diverse in cui la competenza è sparpagliata un po' per il mondo ma che tiene un costante contatto con il nostro Paese e le nostre università. Oltre a reti della conoscenza come queste, mi sono anche occupato di sviluppare il concetto di “comunità educanti”: un concetto presente in pedagogia sin dagli anni Settanta, che oggi si è sviluppato sino a comprendere quelle comunità territoriali in cui scuole, associazioni, enti locali e imprese si coordinano per produrre una conoscenza applicata mirata a contrastare il disagio educativo e a comprendere su quali leve sia possibile insistere per migliorare i risultati dell'apprendimento, mediante precondizioni fruttuose per l'apprendimento stesso, tra cui la motivazione, l'autostima e il senso di sé. Oggi più che mai la valutazione ha molto bisogno dell'elaborazione condivisa di strategie orientate al miglioramento, strategie, ancora una volta, elaborate da soggetti diversi che collaborino insieme».
|
